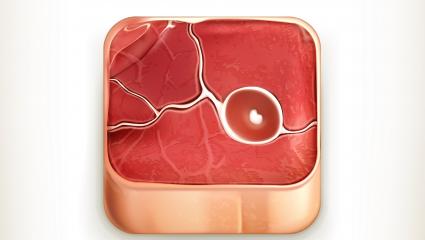La formazione certificata: più valore alle professioni, più garanzia per le aziende
Mag. 7 2019
1. La formazione delle persone come strumento di competitività
“L'arma competitiva del ventunesimo secolo sarà la formazione accompagnata dalle competenze della nostra forza lavoro”. Così recita una delle frasi più citate dell’economista americano Lester Thurow.
La formazione del personale è, senza dubbio, l’investimento “intangibile” che più di tutti può condizionare l’andamento di un’azienda in termini di competitività, capacità di resistere sul mercato, crescita del valore. Almeno fino a quando le organizzazioni aziendali nasceranno e saranno guidate dall’intraprendenza, dalla visione e dall’azione degli esseri umani. E saranno le decisioni di questi – giuste o sbagliate – a decretarne il successo o il fallimento.
Sono ormai diversi anni che il concetto di “investire in formazione” è entrato tanto nel lessico aziendale quanto – anche se in percentuale decisamente minore – nel budget di spesa delle imprese.
Un tipo di formazione che nella maggioranza dei casi riguarda il processo di acquisizione di competenze tecniche e conoscenze teoriche che permettono ai dipendenti di essere aggiornati su questioni e materie specifiche.
In questo senso, l’irrompere sulla scena dell’industria 4.0, intesa come Quarta Rivoluzione industriale, ha messo le imprese di fronte a un bivio: formare i dipendenti (cioè renderli digitalmente preparati) per rimanere competitive o lasciarli al punto in cui si trovano e con grande probabilità venire marginalizzate in un mercato che richiede una costante evoluzione nelle competenze.
2. Oltre le conoscenze specifiche. La formazione come crescita dell’adeguatezza a un ruolo
Tuttavia, ricondurre la formazione al solo apprendimento o acquisizione di conoscenze tecniche e specialistiche è riduttivo. Soprattutto oggi, non è possibile ignorare o sottovalutare l’importanza del “fattore umano” all’interno delle organizzazioni e di quanto l’agire delle persone in azienda possa influire sullo sviluppo del business, sia in termini positivi che negativi.
Un’impresa cresce o perde posizioni anche in base alla capacità o all’incapacità di coloro che vi lavorano di:
• gestire le relazioni fra colleghi e saper contenere o smorzare i momenti di conflitto
• motivare il team e renderlo coeso
• tenere a bada lo stress e l’emotività
• saper decidere nei tempi giusti
• guardare le situazioni in maniera trasversale e ragionare per macro-problemi
• valutare i rischi e, in caso di necessità, avere già immaginato le soluzioni
• esercitare correttamente la leadership.
Infatti, un errore riconducibile a un calcolo sbagliato o una mancanza di conoscenza può avere conseguenze anche gravi e costare all’azienda in termini economici e reputazionali (come la consegna in ritardo o dei prodotti difettosi); tuttavia si tratta di sbagli più facilmente individuabili nel processo di produzione, circoscritti e – nella maggioranza dei casi – correggibili.
Diverso il discorso se a essere scorretto o fuori fuoco è il comportamento, l’atteggiamento professionale o l’approccio al lavoro di un dipendente. In questo caso gli strascichi negativi di un modo sbagliato di gestire l’attività, le persone o i conflitti saranno non solo più complicati da isolare, ma anche più duraturi.
3. La rivincita delle “soft skill” come elementi centrali della formazione aziendale
Ma com’è possibile sapere se una risorsa ha le caratteristiche sopra elencate? Al momento molto circoscritto del colloquio di lavoro le cosiddette “soft skill” sono difficilmente valutabili; chi seleziona il personale è costretto a prendere una decisione guardando solo a caratteri che possiamo definire “hard skill”, elementi che fanno parte del bagaglio di conoscenze teorico-tecniche, verificabili dalle esperienze pregresse e dai titoli di studio o dai diplomi ottenuti.
Inoltre, se è difficile valutare nel corso di pochi incontri – quelli propri di una selezione – se un lavoratore potrà essere adeguato o meno a un determinato ruolo, dopo l’assunzione è praticamente impossibile che gli sia data l’occasione di formarsi con l’esperienza, magari a seguito di errori o incertezze. Al di là delle opinioni personali su quanto sia più o meno giusto, la crescita professionale in contesti aziendali non avviene mai per gradualità.
Ecco dunque che in questi ultimi anni, un tipo di formazione che possiamo definire “comportamentale” e che predilige le soft skill, ha assunto un peso sempre maggiore. E non solamente per le grandi realtà, magari multinazionali, per le quali vi sono criteri più o meno standard da rispettare per ogni livello o posizione all’interno dell’organigramma. Ma anche per quelle realtà più piccole, come le PMI, in cui spesso non vi è – e se ne sente la mancanza! – una figura che faccia da raccordo e sia in grado di razionalizzare i processi che portano alle decisioni, fornendo una visione d’insieme.
Un problema non di poco conto, poiché tra i pericoli che corre una piccola realtà imprenditoriale, magari padronale, vi sono:
• l’impossibilità di fare piani di sviluppo ad ampio raggio, perché costretti dall’urgenza dell’attività quotidiana
• il dover assecondare il volere del proprietario, talvolta lasciato solo nel prendere ogni decisione.
La formazione comportamentale di figure lavorative ha l’obiettivo di minimizzare questi due rischi: infatti contribuendo alla crescita professionale – ma in certa misura, anche personale – dei lavoratori, va a soddisfare un bisogno aziendale.
4. Formazione come questione di cultura (aziendale)
Eppure, pur sapendo o almeno intuendone i benefici, non tutte le imprese sono “culturalmente” pronte o convinte di voler dedicare risorse economiche e tempo alla formazione dei propri dipendenti. Tra le ragioni che portano un’impresa a non prendere in considerazione la formazione del personale ve ne sono almeno 3, tutte a cavallo di quella linea – talvolta molto sottile – che separa il vero impedimento dal pretesto. E cioè:
1. l’urgenza del quotidiano. L’attività corrente, fatta di tante piccole e grandi azioni, tutte urgenti e tutte da svolgere entro la fine della giornata, diviene il primo ostacolo alla formazione, con il lavoratore impossibilitato a perdere nemmeno un’ora del suo tempo.
2. il contenimento dei costi. La scelta di formare un dipendente viene annotata alla voce “costi” e non in quella “investimenti per il futuro”.
3. il turn-over aziendale. Specialmente nelle realtà medio-piccole, il timore non è tanto (o solo) quello di perdere dipendenti, attratti da altre soluzioni lavorative magari in concorrenza, ma di perdere quei dipendenti che sono stati formati e hanno migliorato le proprie competenze.
Appare chiaro come, tutte e tre queste forme di resistenza, affondino le proprie radici in una cultura d’impresa di retroguardia e conservativa. Infatti, senza un’adeguata e continua formazione i rischi per un’azienda sono:
• l’impoverimento delle competenze e l’inadeguatezza del lavoratore nei riguardi delle trasformazioni;
• la fuga di coloro che hanno voglia di crescere professionalmente verso altre realtà aziendali, con il conseguente impatto sull’organizzazione e sui flussi di lavoro, visto che la risorsa persa andrà sostituita con una nuova, probabilmente inesperta o comunque da formare.
In realtà, in un mercato del lavoro e delle professionalità (e, perché no, dei talenti) aperto e flessibile, lo scambio e il ricambio di lavoratori formati e skillati non può che essere un segnale di vitalità in grado di apportare nuove conoscenze, magari sotto forma di metodologie alternative e più efficienti.
5. La certificazione come sicurezza di qualità (e strumento per evitare brutte sorprese)
Come può un’azienda che invece punta sulle competenze trovare dipendenti e collaboratori che rispondano ai suoi criteri e standard di preparazione e professionalità?
Le vie a disposizione sono sostanzialmente tre.
1. La prima prevede che senior esperti affianchino junior in maniera da trasferire conoscenze ed esperienze in un articolato percorso di crescita. Un metodo efficace e arricchente per tutti i soggetti coinvolti ma.... troppo diluito nel tempo e proprio di un passato dove i ritmi erano meno frenetici e i mercati più ristretti. L’interrogativo è: quante aziende oggi sono disposte ad attendere il compimento di questo tipo percorso formativo, senza dubbio molto solido, ma altrettanto lento?
2. La seconda riguarda la formazione professionale dei dipendenti realizzata da elementi esterni all’azienda. Versione moderna e rapida della prima in grado di realizzare percorsi professionalizzanti per ogni tipo di esigenza.
3. La terza prevede la collaborazione – più o meno prolungata od organica – con professionisti specializzati in settori specifici. Persone che possono mettere a disposizione di chi li incarica, sin da subito e senza alcuna attesa, tutte quelle conoscenze e competenze che già possiedono.
Ma come fanno le aziende a essere sicure che quel determinato professionista sia davvero esperto in un certa disciplina? Metterlo alla prova significherebbe usare tempo e risorse economiche che non intendono sprecare.
E allora? La soluzione è affidarsi a quei professionisti che hanno ottenuto un’attestazione da parte di enti terzi che ne dimostra l’idoneità. La certificazione diventa elemento significativo per entrambe le parti.
All’azienda porta:
a. una riduzione del tempo d’inserimento
b. una riduzione dei rischi. Una persona certificata per un determinato ruolo sgrava l’azienda da eventuali conseguenze negative in caso di mancanze, negligenze o errori, anche in sede di contenziosi.
Va da sé che minimizzando questi due fattori è molto probabile una riduzione dei costi, almeno quelli derivanti dalla correzione di situazioni negative.
Ma la certificazione è uno strumento utile anche per il professionista. Le conoscenze acquisite, una volta validate e riconosciute da enti terzi:
a. acquistano valore economico
b. acquistano valore reputazionale
c. ottengono un’identità distintiva, argine e difesa oggettiva contro coloro che, senza avere i titoli, affermano di avere le stesse competenze
Riconoscere l’adeguatezza, l’abilità nello svolgere una professione e difenderne il sapere tecnico-teorico: un bisogno antico che ha dato origine secoli fa alle corporazioni di arti e mestieri e poi agli ordini professionali.
Tuttavia, la pratica di far certificare una professione da un ente terzo – che non rappresenta gli interessi né delle aziende né dei professionisti – si sviluppa meno di trenta anni fa, nei primi anni Novanta del secolo scorso, coinvolgendo in primis la figura dell’auditor.
L’altro grande cambiamento avviene nel 2013, quando viene varata la legge 4 dedicata alle professioni non organizzate in ordini o collegi. Grazie ad essa, tutte le associazioni professionali o i singoli professionisti possono – a seguito dell’elaborazione da parte di UNI della norma tecnica che va a definire la loro competenza – essere certificati da un ente di parte terza (che a sua volta è accreditato presso Accredia, ente italiano preposto).
Con vantaggi e benefici non solo per i professionisti, oggi riconosciuti formalmente per l’attività svolta, ma anche per la collettività, che avrà la sicurezza di rivolgersi a persone competenti, esperte e che operano secondo una serie di criteri codificati e stabiliti.
Ciò vale per l’auditor o il data protection officer, per il security e il safety manager, per il disaster manager, il valutatore immobiliare e l’addestratore cinofilo fino all’estetista oncologica, ovvero per professioni fra loro diversissime, che toccano ambiti a volte estremamente di nicchia.
Ma che hanno un comune denominatore: il bisogno di salvaguardare il loro sapere (e le loro abilità), farsi riconoscerle, perimetrando con chiarezza l’ambito di intervento.